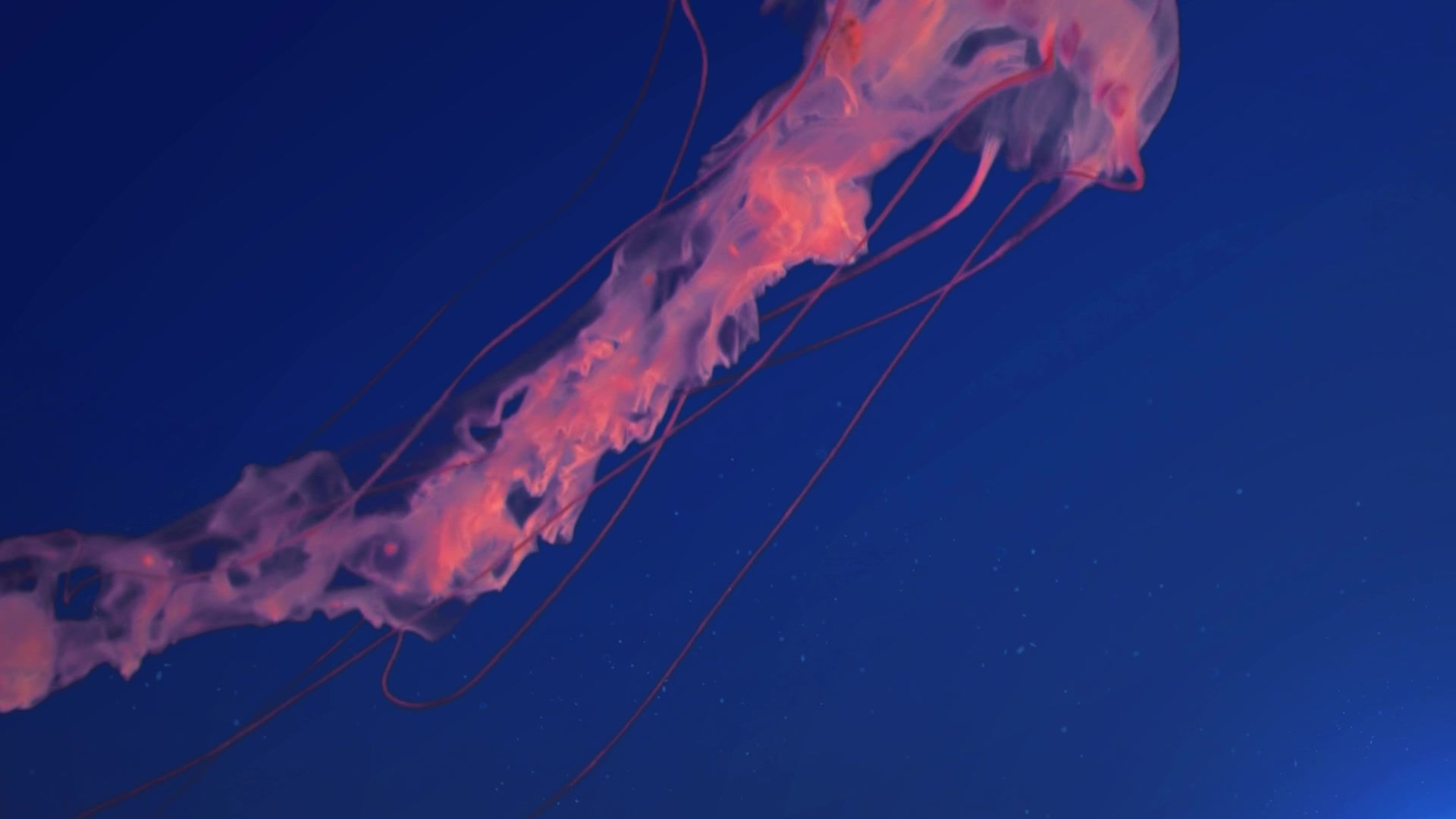
Negli anni la P4C è uscita dalle aule scolastiche per diventare un vero e proprio movimento culturale, che ha coinvolto anche gli adulti.
In diversi ambiti, sia formali che informali, la presenza di facilitatori-teacher in P4C ha consentito di far nascere comunità di ricerca che hanno riportato la filosofia alla sua dimensione pratica e sociale, vicina all’ispirazione che muoveva Socrate e i suoi concittadini ateniesi a filosofare.
PROGETTO:
La Philosophy for Children - Community è la pratica filosofica ideata da Matthew Lipman negli anni ’70 che si pone l’obiettivo di trasformare un gruppo in comunità di ricerca filosofica.
Questa attività è garantita dal facilitatore che, con le sue competenze filosofiche, psicologiche e pedagogiche e una specifica formazione, aiuta i membri della comunità a sviluppare il pensiero complesso: critico, creativo e valoriale.
Si avvale, inoltre, di specifici materiali creati ad hoc: una serie di racconti in forma dialogica in cui i protagonisti, bambini,adolescenti, adulti, animali dialogano su problemi e questioni di natura filosofica, il valore della vita, il pensiero, il rapporto mente-corpo, la verità, la giustizia, la malattia, emergenti dalla loro esperienza.
Ogni racconto è corredato da un manuale per l’educatore, in cui sono fornite indicazioni procedurali e metodologiche funzionali all'approfondimento del lavoro educativo con piani di discussione, esercizi, attività stimolo.
L’educatore in questo caso, come scritto più sopra, è piuttosto un "facilitatore" del processo di ricerca, che segue e stimola attraverso l'uso di domande aperte, interventi di chiarificazione, approfondimento, ricerca di criteri procedurali comuni e condivisibili senza mai orientare il gruppo verso un obiettivo diverso da quello regolativo di fondo: la fedeltà allo spirito della ricerca e dell'indagine, necessariamente aperta, dinamica e virtualmente interminabile.
Il successo di esperienze di P4C con adulti mette in evidenza la “richiesta di filosofia” che è presente anche ai giorni nostri.
Infatti, alcuni degli obiettivi che la P4C intende perseguire sono di grande attualità.
Tra i più importanti, si ricordano:
-
l’educazione alla democrazia, al rispetto dell’altro e della comunità attraverso l’utilizzo della logica non formale, che si differenzia da quella formale in quanto individua di volta in volta i suoi riferimenti logici in base alle “buone ragioni” che vengono espresse e che devono essere condivise dalla comunità (ed è per questo non dogmatica ma critica e problematica)
-
lo sviluppo del pensiero creativo, critico e valoriale
-
lo stimolo e il potenziamento della capacità argomentative (chi fa P4C deve fornire motivazioni condivisibili alle sue argomentazioni)
-
il superamento della posizione egocentrica e individualistica (dal confronto polemico e dogmatico si passa al contributo della ricerca all’interno della comunità)
-
lo sviluppo della riflessione meta cognitiva che faciliti l’autoanalisi dei propri comportamenti e delle personali posizioni etiche e valoriali
-
acquisizione della consapevolezza della complessità del pensiero dell’altro.
-
Superamento, accettazione e motivo di confronto della propria situazione attuale di salute.
Nella P4C si è individuato un metodo che, non solo in teoria, ma soprattutto nella sua applicazione pratica stimola il pensiero critico e pone le basi per una concreta vita democratica mirante alla partecipazione comune e al rispetto del singolo e della comunità.
Tale attività dialogico-riflessiva è dunque anche un importante momento di crescita per la collettività.
“ COMUNITA’ DI RICERCA “
Il gruppo inteso come comunità di ricerca è lo spazio della valorizzazione del dubbio, della domanda, del problema.
In esso l’apprendimento è inteso come processo di scoperta che si attiva grazie alla possibilità offerta al gruppo di esplorare direttamente e motivatamente i vari campi di conoscenza, che in questo modo divengono veri e propri campi di indagine.
Nella comunità di ricerca i membri sono tenuti insieme dalla condivisione dei problemi e delle procedure utilizzate per risolverli e prendere decisioni, ma anche dal riconoscersi reciprocamente come giudici indipendenti e allo stesso tempo come compagni di avventura.
Una comunità che si raccoglie intorno al desiderio e al bisogno di ricerca è una comunità che trova la sua identità e stabilità entro il disequilibrio necessario per fare un passo avanti, grazie alla ponderazione condivisa del rischio e al sostegno reciproco nello sforzo cognitivo ed emotivo che la ricerca comporta.
Nei vari progetti che ho attivato propongo dei percorsi ad hoc a seconda dell'utenza.
Bambini: utilizzerò i testi di Lipman. Letture condivise anche con l'aiuto dei burattini.
Adolescenti: i testi di Lipman e canzoni di cantautori ed interpreti italiani.
Adulti: libri tra cui " Ho ballato con uno sconosciuto" di Carolyn Smith e canzoni di cantautori ed interpreti italiani.
Pazienti oncologici: libri, tra cui " Ho ballato con uno sconosciuto" di Carolyn Smith e canzoni di cantautori ed interpreti italiani.
Case di Riposo: libri, tra cui " Ho ballato con uno sconosciuto" di Carolyn Smith e canzoni di cantautori ed interpreti italiani. In alcuni casi anche poesie o piccole frasi tratte da vari autori.
MATERIALI:
-
cartelloni, o fogli A3,
-
pennarelli,
-
forbici e colla,
-
piccoli giochi per l'attività iniziale e di autovalutazione finale,
-
un lettore cd classico o con presa usb,
-
fotocopie dei testi – frasi etc.. che verranno utilizzati
I cartelloni contenenti le agende e i piani di discussione li raccoglierò ad ogni incontro per poter dar vita ad un libro che rimarrà come storico all’interno della struttura.
TEMPI:
1 volta a settimana per gruppo.
1 ora di attività dialogica.
Alcune parti sono prese dalla mia Tesi di Laurea e dal sito http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4children/